37 So che siete discendenti di Abramo. Ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. 38 Io dico quello che ho visto presso il Padre; anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro». 39 Gli risposero: «Il padre nostro è Abramo». Disse loro Gesù: «Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo. 40 Ora invece voi cercate di uccidere me, un uomo che vi ha detto la verità udita da Dio. Questo, Abramo non l’ha fatto. 41 Voi fate le opere del padre vostro». Gli risposero allora: «Noi non siamo nati da prostituzione; abbiamo un solo padre: Dio!».
Giovanni 8,37-41
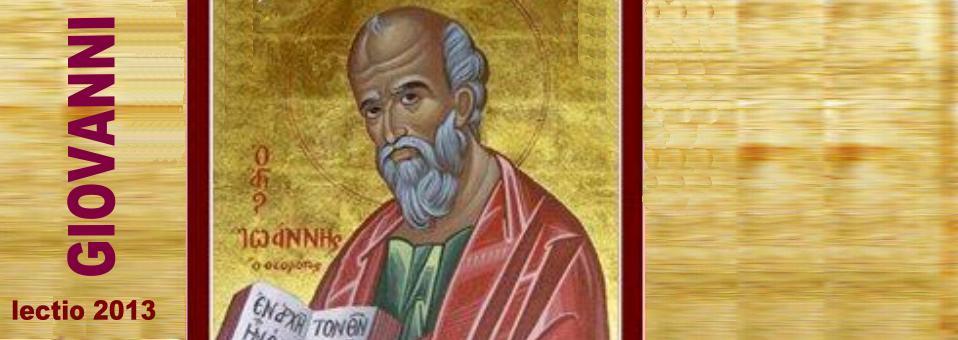


Premetto che con timore oggi comunico il pensiero che mi ha visitato attraverso queste parole. E’ sempre un po’ così, ma oggi la scommessa è molto alta. Sono sempre governato dalla parola che ieri ascoltavamo circa il peccato, che prima di essere una colpa, è una schiavitù: “chiunque commette il peccato è schiavo del peccato”; e il grande annuncio di Gesù : “Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli; conoscerete la verità e la verità vi farà liberi”, dove la conoscenza della verità è l’esperienza di essa, e non solo una conoscenza intellettuale. Dunque, donandoci la sua Parola, Gesù ci conduce in un cammino di liberazione dal male. Riprendo queste considerazioni, perché mi sembra che il dibattito che oggi avviene tra Lui e i Giudei abbia proprio questo contenuto. Gesù, che non ha condannato ma ha liberato la donna adultera, spiega che questa è l’azione divina che Egli è venuto a rivelare e a comunicare.
Gesù rivendica la profonda unità di tutta la storia della salvezza, e afferma l’unità profonda tra la fede di Abramo e la parola che ora Egli annuncia. Parola che però in loro “non trova accoglienza”(ver.37). Quindi in realtà non sono veramente “discendenti di Abramo”, perché non fanno “le opere di Abramo”(ver.39). L’opera di Abramo è la fede! I Giudei non compiono quest’opera, perché non credono in Gesù che dice quello che ha visto presso il Padre. La loro è quindi solo una discendenza carnale da Abramo, e non quella sostanziale della fede: “Se foste figli di Abramo, fareste le opere di Abramo”(ver.39).
Dunque i Giudei respingono l’opera di liberazione che Gesù è venuto a compiere, liberando l’umanità dalla schiavitù del male e della morte. Se è così, non c’è il pericolo che anche “noi” di fatto costruiamo una “giustizia di Dio” che piuttosto che liberare, condanna? Sarei molto grato a chi di voi mi volesse aiutare in questo tema che secondo me è delicatissimo.
Dio ti benedica. E tu benedicimi. Tuo. Giovanni.
Caro don Giovanni,
il passo di Giovanni di oggi, e il suo commento mi hanno suscitato alcune riflessioni che risentono anche della lettura di un libro di un teologo che amo molto. Credo che uno dei motivi per i quali rifiutiamo istintivamente la liberazione propostaci da Cristo, è il fatto che essa implichi l’accettazione della croce. Perché quello che Cristo ci propone è proprio questo: che criterio delle nostre scelte sia non il nostro desiderio, ma la risposta all’appello che per noi costituisce il bisogno dell’altro. Confondiamo l’amore con un sentimento spontaneo che deve implicare per noi una gratificazione, una qualche forma di riconoscimento, mentre invece è l’esercizio di un atto di reponsabilità assolutamente gratuito e che può implicare la croce. E’ difficilissimo da accettare, anche per i credenti. Per cui risulta più facile costruire una giustizia fatta di norme da rispettare, gratificante per chi le definisce e per chi riesce a rispettarle, frustrante per chi non riesce a starci dentro.
Ho pensato di fare cosa utile riportando un passo del teologo cui accennavo: passo che, pur non parlando esplicitamente del rapporto tra schiavitù del peccato e liberazione portata da Cristo, mi sembra abbia molto a che fare con le dinamiche da esso implicate:
“Gratuito è ciò che vien dato senza chiedere ricompensa: né in danaro né, per estensione e approfondimento, in altre forme di promozione dell’io. E’ dunque facile escludere dall’idea di gratuità quei comportamenti ai quali inerisce un’attesa di riconoscimento di questa stessa gatuità, almeno, un’attesa tale da diventare surrettiziamente la ragione stessa del comportamento adottato (il quale starebbe allora all’autentica gratuità come il perbenismo sta alla pratica seria del bene). Né le cose cambiano se il riconoscimento, invece che atteso dall’esterno, viene dispensato dall’io a se stesso, in quella superiore forma di narcisismo che è l’autocompiacimento spirituale.
Ma tutto questo è noto, perché una lunga tradizione di scritti – dai maestri di spiritualità ai suoi dissacratori – vi ha puntato una accurata o beffarda attenzione. Meno noto è che, accanto a questi vizi individuali, v’è almeno una figura di gratuità che presenta un deficit ben più sostanziale perché non individuale-biografico ma specifico: è la figura della spontaneità. Amore gratuito sarebbe quello dove la generosità, la disponibilità, il servizio sono così naturali da effondersi con la stessa grazia della natura a primavera. La faccia severa del dovere è qui trasfigurata nella dolcezza della bontà, nella bellezza del ‘sorriso solare’.
Senonché, proprio questo afflato che rasenta il sovrumano tradisce la sua vera natura pre-umana, la sua radicazione in ciò che, dentro l’individuo, non è veramente individuale, anteriore alle sue scelte, è congiuntura di un’indole fortunata, non frutto di libera decisione. La seduzione di questa figura di gratuità è l’altra faccia della rassegnazione ai comportamenti violenti o debosciati, effetto di un’indole (o di una storia: ambiente, educazione) distorta. Grazia della bontà o disgrazia della malvagità sono le due forme speculari della deresponsabilizzaione: l’atto che scaturisce da me non è ultimamente mio.
La gratuità di un atto autenticamente umano, a differenza della grazia della natura, può essere soltanto una figura della libertà: il suo aderire al bene – al neme dell’altro – per via di decisione militante che rifiuta la possibilità del male, non per via di irresistibile attrazione. Ed ecco allora la domanda: quale forza alternativa all’attrazione può motivare la mia adesione all’altro, la mia volontà di bene nei suoi confronti? Semplicemente: la convinzione che offrirgli quel bene è necessario, di quella singolare necessità della libertà che è il suo dover-essere. Il dover-essere sta tra la mia libertà e l’altro come la luce sta tra il mio occhio e l’oggetto: una mediazione che istituisce assieme la distinzione e la relazione, la distanza e l’alleanza. Il dover-essere è la luce della libertà nella modalità del giudizio “è giusto”: di costui/costei che mi sta davanti non so nulla se non il suo bisogno del mio soccorso e la trasvalutazione di quel bisogno da fatto a diritto e di quel soccorso da possibilità a necessità della mia libertà. Perciò quel soccorso è gratuito: offrendolo, non ho accumulato crediti presso l’altro, ho sciolto quel debito che ho contratto nei suoi confronti per la semplice presenza del suo bisogno. L’amore è gratuito perché è dovuto. Non che debba pagare all’altro un debito precedente (in questo caso scomparirebbe la gratuità): il mio debito è il suo bisogno letto alla luce del mio dovere di colmarlo.
In questo senso si uò dire, con il filosofo ebreo E. Lévinas, che esistere è essere in debito; aggiungendo che l’assolvimento di questo debito è pure, nel senso più proprio, la gratuità di un dono. Soltanto nella simultanea coscienza che l’intera vita spesa per gli altri non fa di me un eroe, e che il più piccolo gesto di aiuto fa di me un regale donatore, si disegna la verità dell’esistenza etica”
Armido Rizzi, Oltre l’erba voglio. Dal narcisismo postmoderno al soggetto responsabile, Cittadella, Assisi 2004, pp. 176-178.
grazie don giovanni x questi succosi graditi commenti semplici e comprensibili.”coraggio avanti con la fiducia
del cuore”(frase di d giannitomasi)